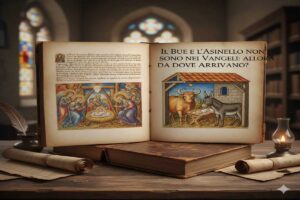Dalla Trieste asburgica alla Roma occupata, il percorso di Israel (poi Eugenio) Zolli tra erudizione biblica, persecuzione e un passaggio di fede che ancora divide
Israel Zolli, figura emblematica che periodicamente riscalda i dibattiti sulla memoria pubblica italiana e i delicati rapporti tra ebraismo e cattolicesimo, ha segnato la storia con la sua controversa conversione al cristianesimo nel 1945.
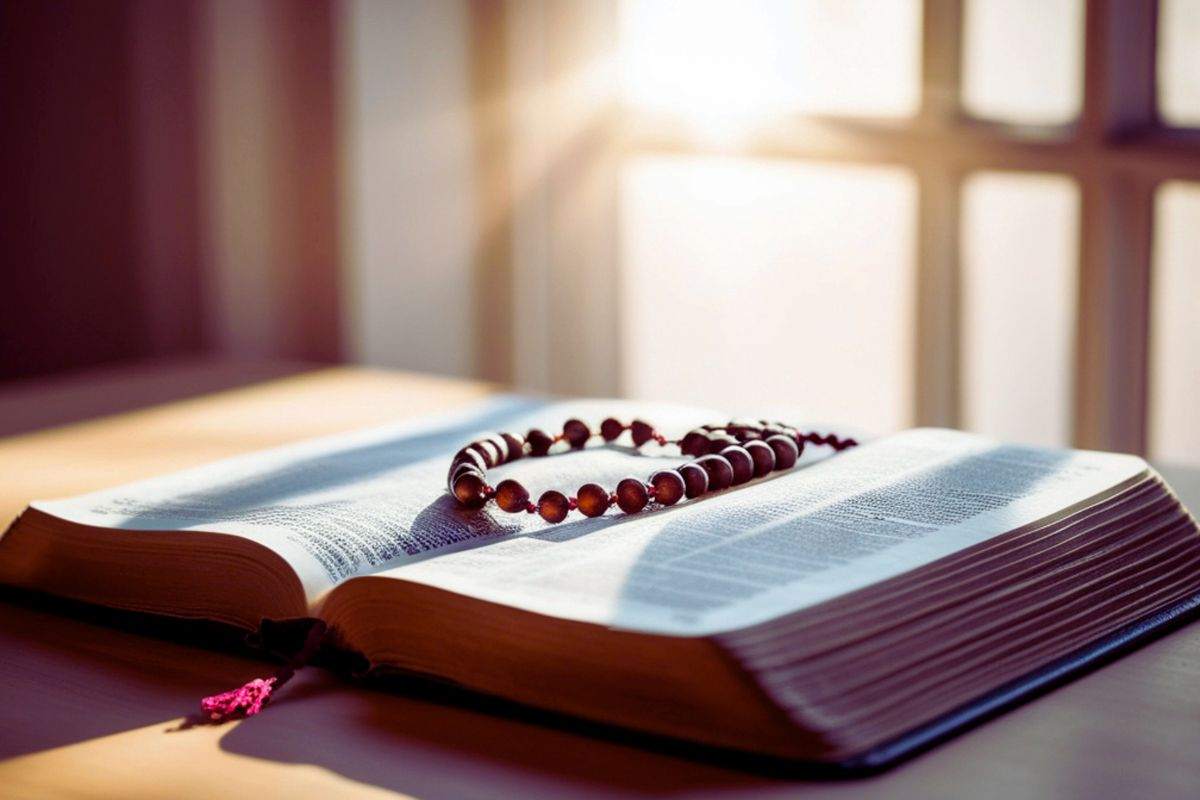
La sua vita, intrecciata con gli eventi tragici del Novecento e con la particolare storia dell’ebraismo italiano, si ripresenta come argomento di riflessione ogni volta che convegni, libri o rassegne culturali ne esaminano la complessa figura.
Nato nel 1881 a Brody, nell’allora Galizia austro-ungarica, Zolli si distinse per i suoi studi rabbinici e per un approfondito percorso accademico in filologia e filosofia. La sua carriera lo portò a Trieste nel 1918, dove divenne rabbino capo di una delle comunità più vivaci d’Italia, distinguendosi per la sua rigorosa esegesi biblica e per il dialogo con il mondo laico e le scienze umane emergenti.
Tuttavia, le leggi razziali del 1938 segnarono una svolta drastica nella sua vita, costringendolo a trasferirsi a Roma e ad assumere un ruolo centrale nella vita religiosa e civile dell’ebraismo italiano.
Una storia di conversione
La capitale lo accolse in un periodo buio, segnato dalla guerra, dall’armistizio e dall’occupazione nazista. Durante la razzia del 16 ottobre 1943 e la conseguente persecuzione degli ebrei, Zolli si adoperò per salvare vite, nascondere registri e mantenere unita la comunità. La sua posizione lo portò a cercare sostegno anche al di fuori dei consueti perimetri, inclusa la Santa Sede, incrociando così la figura di Pio XII, al centro di un dibattito ancora aperto tra chi lo vede come protettore degli ebrei perseguitati e chi invece invita a una lettura più cauta e critica.

La decisione di Zolli di convertirsi al cristianesimo, avvenuta nel febbraio del 1945, fu il risultato di un lungo percorso interiore, influenzato dalla lettura dei profeti, dalla sofferenza della guerra e da un’intensa esperienza spirituale. Nonostante egli negasse che il suo fosse un gesto politico, la sua conversione fu accolta con durezza dalla comunità ebraica, che la interpretò come un abbandono in un momento di profonda sofferenza e perdita.
Dopo il battesimo, Zolli visse lontano dai riflettori, dedicandosi all’insegnamento delle lingue semitiche e dell’esegesi biblica. La sua competenza rimase indiscussa, ma la sua biografia continuò a essere oggetto di dibattito, simbolo di un ponte tra due mondi per alcuni, di una ferita per altri. La sua figura è stata periodicamente riconsiderata nel contesto del dialogo ebraico-cristiano, a volte come esempio positivo, altre come caso controverso.
Il dibattito sull’eredità di Zolli e sull’interpretazione del suo percorso rimane vivo, soprattutto in relazione al ruolo della Chiesa durante la Shoah e all’uso pubblico del suo nome. Le aperture degli archivi e le nuove ricerche offrono l’opportunità di esplorare la sua storia con maggiore complessità, evitando semplificazioni e strumentalizzazioni.
Un recente evento culturale ha messo in luce il profilo di Zolli come uomo di frontiera, che ha attraversato le rovine del suo tempo alla ricerca di orientamento nel testo sacro e nell’esperienza vissuta. La sua storia, ricca di sfaccettature e resistente a interpretazioni riduttive, invita a un approccio attento e rispettoso, che consideri la complessità delle biografie e dei contesti storici, senza cedere alla tentazione di ridurre la narrazione a semplici etichette o a strumento di scontro identitario.