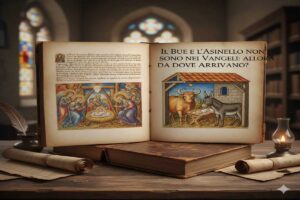Un appello circolato nelle scorse ore e rilanciato dalle agenzie ha riacceso un tema che periodicamente attraversa il mondo della cultura e quello ecclesiale: dichiarare Santo Michelangelo Buonarroti perché le sue opere sarebbero, in sé, “miracoli”.
Nella formula scelta dai promotori, la richiesta è rivolta a “Papa Leone”, un richiamo che ha acceso curiosità e discussioni: per alcuni è un riferimento evocativo alla tradizione dei pontefici che hanno portato il nome Leone, per altri un rimando storico a Leone X, uno dei papi del Cinquecento con cui Michelangelo ebbe rapporti, per altri ancora una formula simbolica per indicare il Pontefice in carica.

Al centro dell’appello c’è un argomento che tocca corde profonde: la Pietà, il David, gli affreschi della Cappella Sistina, il Mosè e i cicli scultorei e pittorici dell’artista sarebbero “miracoli” non solo in senso metaforico di eccellenza assoluta, ma come segni di una grazia capace di trasfigurare la materia. Per i sostenitori, la potenza spirituale di quelle immagini ha generato, lungo i secoli, conversioni intime, consolazioni, un’educazione dello sguardo e del cuore che travalica le categorie estetiche, lambendo l’esperienza religiosa.
La proposta, tuttavia, incrocia una prassi canonica precisa. Nel diritto della Chiesa, la santità non è riconosciuta per il solo genio o per i frutti culturali, ma per l’eroicità delle virtù cristiane e per l’intercessione presso Dio, comprovata ordinariamente da miracoli postumi, spesso di natura medica, sottoposti a indagini rigorose. Il cammino prevede tappe distinte — Servo di Dio, Venerabile, Beato, Santo — sotto la responsabilità del Dicastero delle Cause dei Santi. Esistono eccezioni, come la canonizzazione equipollente, riservata a figure con culto immemorabile e fama di segni straordinari; anche questa via, però, non si fonda sulla grandezza artistica in sé.
È su questa linea di demarcazione che si collocano le prime reazioni. Nel fronte favorevole, storici dell’arte e credenti sottolineano come la categoria di “miracolo” non vada schiacciata su quella clinica: un’opera che, secoli dopo, continua a generare fede, speranza e carità, che apre alla contemplazione e alla preghiera, sarebbe un “segno” in senso biblico, un varco verso il Mistero. Nel fronte critico, teologi e studiosi ricordano che la santità riguarda la vita del soggetto e la sua perseveranza nelle virtù cristiane; il rischio, dicono, è confondere l’azione dello Spirito con il fascino del capolavoro, facendo scivolare il discernimento dal piano spirituale a quello del gusto.
Chi è Michelangelo Buonarroti?
Michelangelo, nato nel 1475 e morto nel 1564, ha attraversato alcune delle stagioni più complesse della Chiesa e dell’Europa. Lavorò per più pontefici, si misurò con committenze titaniche, segnò con la sua mano la teologia visiva dell’Occidente. Fu uomo dalla fede inquieta e profonda, autore di rime religiose e meditazioni, artistica coscienza acuminata del peccato e della redenzione. La sua vita, tutt’altro che monastica, fu scandita da scontri, ripensamenti, ardori: una trama umanissima che alimenta sia l’ammirazione sia la cautela di chi osserva oggi la proposta di un riconoscimento canonico.

Non mancano i precedenti che invitano alla riflessione. Un artista come Fra Angelico è beato; santi come Caterina da Bologna sono patroni delle arti; l’evangelista Luca è venerato come patrono dei pittori. La Chiesa, insomma, conosce la possibilità che il talento creativo si unisca alla santità, ma sempre attraverso il vaglio della vita virtuosa e della fama di intercessione, non per la sola forza di un catalogo di opere. Al tempo stesso, nessuno nega che i capolavori possano essere luoghi di esperienza spirituale e di evangelizzazione straordinaria.
La scelta di evocare “Papa Leone” ha un valore comunicativo potente. Richiama una stagione in cui arte e Chiesa dialogavano in una vicinanza a tratti conflittuale ma feconda; sollecita, oggi, una domanda più ampia: in che modo le istituzioni religiose riconoscono e accompagnano quei linguaggi che, fuori dalla liturgia, conducono alla soglia del sacro? Che nome dare a quello stupore che, davanti a un volto scolpito o a un cielo affrescato, muove alla preghiera?