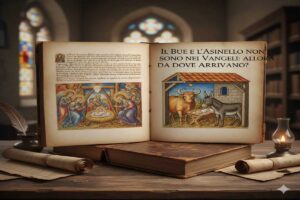Oggi, 29 settembre, la Chiesa latina celebra San Michele Arcangelo, figura centrale dell’immaginario cristiano e ponte simbolico tra Scrittura, liturgia e cultura popolare.
Il suo nome, di origine ebraica, suona come una sfida: “Mi-kha-El?”, “Chi è come Dio?”. È il grido che la tradizione gli attribuisce nella lotta contro il male, immagine potente che attraversa secoli di fede e di arte.

Nella Bibbia, Michele emerge come il protettore del popolo di Israele e come guida delle schiere celesti. Nel libro di Daniele appare quale “gran principe” che difende i giusti nei tempi di tribolazione. Nella Lettera di Giuda lo troviamo alle prese con il misterioso contenzioso sul corpo di Mosè, episodio stringato ma dal forte impatto teologico. Nell’Apocalisse di Giovanni, poi, guida gli angeli nella battaglia contro il drago antico, simbolo del male: un duello cosmico che ha forgiato la sua iconografia più nota, con spada o lancia, il mantello spiegato e il demonio schiacciato sotto i piedi.
La devozione a San Michele si radica presto nella cristianità. In Occidente, uno dei poli storici è il santuario sul Gargano, a Monte Sant’Angelo, in Puglia: una grotta che la tradizione lega ad apparizioni tra V e VI secolo e che diviene meta di pellegrinaggi di re, guerrieri e popolo.
Luogo di passaggio e di potere, il Gargano fa di Michele un patrono di frontiera, adottato dai Longobardi e poi dai Normanni, fino alla consacrazione UNESCO come parte dei “Luoghi del potere” altomedievali. Dal Gargano il culto dilaga: verso la Normandia, dove sorge Mont Saint-Michel, abbazia rocciosa che pare nascere dalle maree; e in Britannia, con St Michael’s Mount, isolotto gemello per suggestione e leggende.
San Michele Arcangelo, il racconto
Nelle Chiese d’Oriente, Michele è onorato l’8 novembre nella Sinassi dei Principi delle Potenze Incorporee, festa che ne sottolinea la natura angelica insieme a Gabriele, Raffaele e agli altri “senza corpo”. Nell’Islam è Mīkā’īl, menzionato nel Corano come angelo della misericordia, legato al nutrimento e alla pioggia. In questo crocevia di fedi, la sua figura conserva tratti comuni: difesa del bene, servizio a Dio, custodia dei popoli.

La riforma del calendario liturgico latino del 1970 ha unito in un’unica data la memoria di Michele, Gabriele e Raffaele. L’antica “Michaelmas”, nel mondo anglosassone, segnava un passaggio dell’anno civile ed economico: il tempo dei raccolti, dei mercati, delle fiere d’autunno. Anche in Italia, la festa di San Michele coincide con settembre che volge, con le prime brume e il rientro alle attività, e molte comunità mantengono fiere e processioni legate al santo: tra le più note, quelle di Caltanissetta, città che lo venera come patrono, e gli appuntamenti del Gargano, dove i pellegrini scendono nella grotta per toccare la pietra e affidare intenzioni e ringraziamenti.
La sua iconografia è codificata ma vibrante: la bilancia per la psicostasia, il “peso delle anime” in vista del giudizio; la spada, simbolo della Parola che discerne; il drago, figura del male vinto. Capolavori come il San Michele di Guido Reni, nella chiesa romana dei Cappuccini, ne hanno fissato l’immagine eroica, sospesa tra teatro barocco e teologia morale. Ma accanto all’arte colta, migliaia di edicole, stendardi e statue processionali raccontano un culto vivo, comunitario, talvolta popolare fino all’istintivo.
Patrono dei poliziotti in Italia e dei paracadutisti in vari Paesi, San Michele è invocato come difensore nella lotta contro le forze avverse. La sua preghiera, “Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio”, introdotta nelle orazioni leonine di fine Ottocento e tuttora recitata privatamente da molti fedeli, esprime la fiducia in un combattimento che è anzitutto spirituale. Non a caso la bilancia, accanto alla spada, rimanda alla giustizia che non si riduce a forza, ma pesa, discrimina, riconcilia.
La pluralità delle tradizioni confluisce oggi in liturgie solenni, veglie e pellegrinaggi. Sul Gargano, come in Normandia, risuona il versetto: “Benedite il Signore, voi tutti, suoi angeli”.